
«Gli arresti siciliani (corruzione e voto di scambio mafioso); le beghe romane (coalizioni d’argilla, delazioni e veleni); le minacce russe (il gas no, l'incubo nucleare sì); le ingerenze internazionali (Putin, Von der Leyen); i disastri planetari (il ghiacciaio della Marmolada e l'alluvione delle Marche gli ultimi in Italia). E il Covid che va e torna. E la crisi che torna e non va. E le bollette che salgono. E i redditi che scendono. Il fardello che ci porteremo addosso andando oggi a votare per le politiche e le regionali è pesante ed eterogeneo. Resta da capire quanto potrà pesare sulle nostre scelte».
Soprattutto in Sicilia, dove saremo chiamati a un duplice pronunciamento, imprevedibile fino a un paio di mesi fa. Avendo la lunatica rissosità della politica italiana e siciliana (quest'ultima però sempre più un marginale surrogato della prima) accelerato i tempi del ritorno alle urne, non è però ancora chiaro se questa concomitanza politiche-regionali mobiliterà o incasinerà le coscienze degli aventi diritto al voto. Oggi si guarda ancora con inquietudine alla marea astensionista e con opportunistica ambizione e alla massa informe degli indecisi. Ma se, come sempre, le ultimissime ore possono anche spostare sottili e indefiniti equilibri, è già alla chiusura delle urne che – chiamati al silenzio elettorale dall'italica archeologia legislativa che sconosce il mondo social – vogliamo cominciare a guardare. A cominciare dalle nostre latitudini.
È troppo chiedere – auspicare, pretendere - che il prossimo sia un presidente della Regione autorevole e referenziato, credibile ed affidabile, capace di affrontare e risolvere i problemi, di definire reali priorità e pianificare efficaci politiche di gestione e sviluppo? Il rischio di ritrovarsi a Palazzo d'Orleans figure inesperte o evanescenti, eteree o poco avvezze ai siculi tormenti, così come il pericolo di affidarsi alla protesta per la protesta senza che questa sappia poi trasformarsi in proposta, sono lussi che non ci possiamo permettere. Tanto quanto quello di avere maggioranze instabili e governi ballerini, che compromettano la già non facile guida della cosa pubblica al di qua dello Stretto. La scelta di affidarsi a uno dei candidati in corsa è delegata agli elettori, il dovere di non tradirne la fiducia rendendo conto a loro prima che a generali e attaché di partito è tutto del prossimo eletto. Chiunque esso sia. Le emergenze sono tutte sul piatto: la regressione economica sarà pur figlia di congiunture internazionali (sanitarie, politiche, militari, energetiche) non dipendenti da colpe e volontà direttamente riconducibili alla classe di governo siciliana. E però certamente qui risulta aggravata da una burocrazia-fardello invisa a tutti ma più che mai centro di potere assoluto (chiedere alle migliaia di creditori di mamma Regione); da un evidente ribasso del peso politico che siamo in grado di esportare oltre i nostri confini, figurarsi se spendibile ai tavoli romani (la formazione delle liste, cariche di paracadutati e papi stranieri, amici e fidanzate, figli e pupilli, senza alcun legame con l'Isola, ne sono l'eloquente dimostrazione); da una sostanziale apatia e ignavia nel definire scelte e decisioni reali, oltre i propositi e i proclami di facciata (dai termovalorizzatori alle grandi infrastrutture per la mobilità); da un chiaro ed evidente approccio clientelare alle questioni gestionali (dai dirigenti che si autogiudicano e autopremiano, al proliferare di società satelliti, enti-microbo e precariato dilagante, fra il silenzio complice e la strategia connivente della politica). E dunque prendersela con la Lehman Brothers l'altroieri, il Covid ieri, Putin oggi e chissà chi altri domani può avere un senso solo se non diventa un pretestuoso alibi. E spesso lo è diventato. Veniamo dalle turbolenze mafiose dei governi di Cuffaro e Lombardo, placcate traumaticamente nelle aule dei tribunali (con esiti dissimili); dai frizzi e lazzi del quinquennio di Crocetta, adagiato su un presunto sistema di potere politico-economico che in quegli stessi tribunali è tuttora passato ai raggi x; dall'instabilità del lustro di Musumeci, a cui in tanti hanno contestato il low profile iniziale e allo stesso tempo lo straripamento egocentrico finale. Storie diverse per una Sicilia sempre più attorcigliata su se stessa. Che non muta i suoi atavici problemi. Ma si limita ad incancrenirli.
Contemporaneamente, da Vipiteno a Capo Passero ci sarà da scegliere cosa farne di questa Italietta umorale e bislacca. Che dalle ceneri economiche del Covid prima e della guerra in Ucraina poi stava perfino tirandosi su meglio di altri. Grazie a un Pil cresciuto il triplo di quello tedesco, a 740 mila nuovi posti di lavoro, ad un accumulo di riserve di gas fra i più alti d'Europa, a una credibilità internazionale foriera di concreti effetti (a noi la fetta più grande dei fondi del Pnrr). E a un premier strappato a forza all’élite economica internazionale, mai cimentatosi in politica e però capace in pochi mesi di conquistarsi il titolo di World Statesman, statista mondiale, dall’organizzazione per i diritti umani, la libertà religiosa, la tolleranza e la pace Appeal of Conscience Foundation. E mentre lui a New York – bistrattato e ripudiato da chi ancora siede nel suo stesso governo - riceveva il riconoscimento dalle mani del quasi centenario Henry Kissinger, da queste parti la sua ex maggioranza di unità nazionale si sbrindellava fra interessi di bottega e ripicche di principio. In piena linea con i venti bizzarri dell'ultima fase della tanto decantata Seconda Repubblica (che non si capisce se sia nel frattempo diventata terza, quarta o chissà che): quattro anni di legislatura, due premier – ignoti al corpo elettorale del 2018 - tre distinte maggioranze e un presidente della Repubblica rieletto per incapacità manifesta di trovare un'alternativa. E ora sotto col premier numero 70 della storia repubblicana.
La campagna elettorale si è giocata tutta su manovre delatorie e rigurgiti ideologici – esternati o rinfacciati, dipende dal punto di vista - prettamente anacronistici, ma che costituiscono comunque un buon rifugio dal nulla delle idee o dall'utopia delle promesse (le prime come le seconde mischiate in un polpettone a forte tasso di indigeribilità). Fra chi arranca a tratteggiare scenari post-apocalittici per giustificare la propria probabile debacle e chi galoppa sui sondaggi e però si rimira un po' troppo i muscoli. La parola agli elettori. Per fortuna, certo. Ma con non poca apprensione. Perché se è vero che David Lloyd George - lo statista che traghettò la Corona britannica, così di moda in questi giorni, oltre la Grande Guerra – diceva che «le elezioni sono la vendetta del cittadino e la scheda di voto è un coltello», è altrettanto vero che Winston Churchill – che a quella stessa Corona la successiva guerra la fece vincere - ammoniva che «il miglior argomento contro la democrazia è una conversazione di cinque minuti con l’elettore medio». E pensare che non avevano ancora inventato Facebook, Twitter, Tik Tok...

Scopri di più nell’edizione digitale
Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Persone:




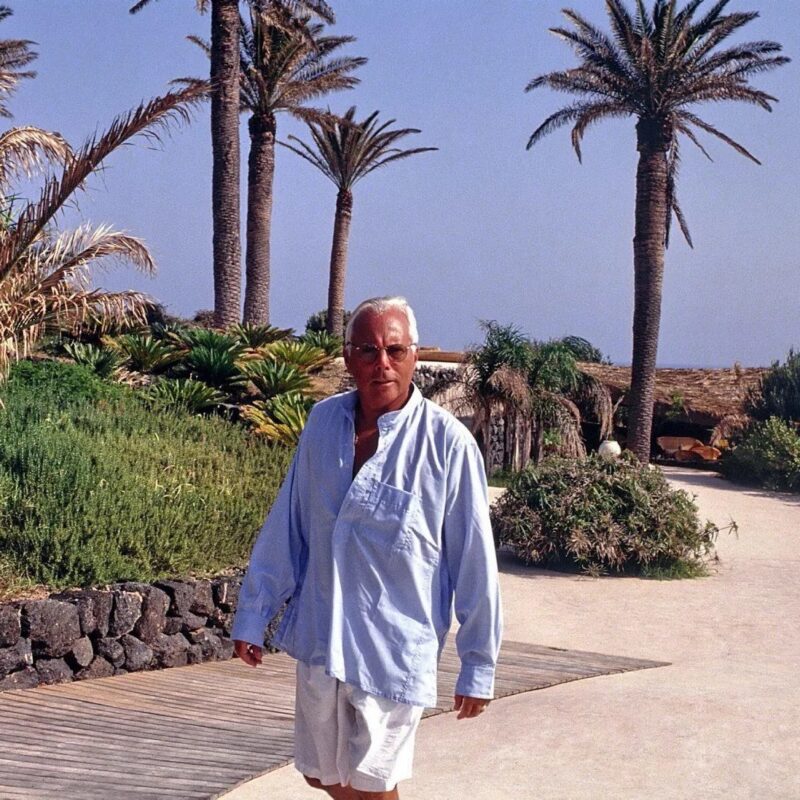




Caricamento commenti
Commenta la notizia