«Il leggendario procuratore antimafia». Così Re Carlo d’Inghilterra ha ricordato Giovanni Falcone in Parlamento durante la sua recente visita in Italia. E giustamente Maria Falcone, la sorella del magistrato assassinato a Capaci il 23 maggio del 1992, ha voluto ringraziarlo pubblicamente.
Per noi palermitani, però, «l’eroe repubblicano», come lo ha definito lo storico Nino Blando qualche giorno fa su questo giornale, non è solo una «leggenda». È molto, molto di più. Lungi, infatti, dal collocarsi nel pantheon delle figure che vanno commemorate per «dovere d’ufficio», la sua storia ci interroga ancora oggi, ci chiede il conto di quel che abbiamo fatto dopo la sua morte, in tutti gli anni trascorsi da quel giorno terribile in cui il tritolo mafioso portò via la sua vita, quella di Francesca Morvillo e dei tre poliziotti della scorta. Sì, proprio così. Ci interroga e ci mette allo specchio. Le manifestazioni memoriali vanno bene, i convegni commemorativi pure e perfino i musei sono utili.
Il punto, però, è: a che punto siamo nella lotta alla mafia in Sicilia e a Palermo in particolare? Perché se vogliamo estrarre alcuni tratti della ricca personalità di Giovanni Falcone, emergono tre caratteri distintivi tra gli altri: la professionalità di giurista, la sobrietà nello stile, la fedeltà istituzionale nel metodo. Chiunque ambisca a operare sotto il patrocinio dell’esperienza storica di Falcone farebbe bene a non dimenticare come lavorava e «stava nel mondo» Giovanni Falcone. Sia chiaro: non perché aveva sempre ragione (la corsa a dargli comunque ragione ex post è inutilmente stucchevole e spesso ipocrita), bensì per rimanere coerenti con quello spirito innovatore che lo condusse a compiere scelte non proprio sintoniche con il main stream dell’epoca, soprattutto nel suo ambito professionale. Come quando - dopo essersi candidato al Consiglio superiore della magistratura (primavera del ’90) senza risultare eletto - decise, con il tramite anche dell’allora capo dello Stato Cossiga, di affiancare il ministro della giustizia Claudio Martelli nel governo presieduto da Giulio Andreotti a febbraio del ’91. Una scelta coraggiosissima e controcorrente che insieme alle riforme elaborate e realizzate in pochissimo tempo grazie a quell’incarico (basti pensare, per tutte, alla prima legge sui pentiti e a quelle che hanno introdotto le attuali DDA e DNA), fu fortemente avversata dai suoi colleghi (compreso il suo amico di sempre Paolo Borsellino che firmò la lettera pubblica di un centinaio di magistrati che contestava l’introduzione della Procura nazionale antimafia) e da aggueritissimi settori politici.
Ma torniamo allo stato di salute attuale della lotta alla mafia. Sul piano legislativo, il quadro generale esibisce un’apprezzabile continuità sul triplice versante processualistico, penale e delle misure di prevenzione. Sotto quest’ultimo punto di vista, alcune importanti innovazioni degli ultimi anni stentano tuttavia ad attecchire nella prassi. In particolare, le misure che consentirebbero ai prefetti e ai Tribunali di «bonificare» le imprese incappate in forme di condizionamento mafioso, senza metterne a rischio l’operatività produttiva e lasciando ai titolari la gestione diretta delle loro aziende, vengono assai trascurate dagli attori istituzionali che prediligono, invece, i tradizionali strumenti del sequestro e della confisca, da un lato, e le famigerate interdittive, dall’altro. Un approccio, quindi, arretrato (e sub iudice al livello europeo e domestico per ragioni di garanzie) che rischia di determinare un doppio risultato negativo: quello cioè, di «prendere troppo poco» o quello, all’opposto, di «prendere troppo». Tale orientamento induce anche a pensare che gli indubbi successi ottenuti sul piano giudiziario negli ultimi anni (da un conteggio ancora da verificare, risulta che dal primo gennaio 2023 sarebbero più di 500 gli individui colpiti da misure cautelari confermate dal Tribunale della libertà per reati di mafia nel distretto palermitano) non devono farci cullare sugli allori. Cosa nostra è sì indebolita come mai nella storia della Repubblica, tanto da non riuscire più a darsi quella struttura piramidale di governo che nel recente passato l’ha resa l’organizzazione criminale più pericolosa al mondo, e tuttavia mostra una capacità di resistenza nel territorio che impone di tenere la guardia alta e – soprattutto – una capacità di leggere in modo aggiornato il radicamento sociale di cui ancora gode, la reale dimensione «genealogica» del contagio mafioso, nonché le evoluzioni dei rapporti tra mercati legali e circuiti criminali. I mafiosi non sparano più ed è un risultato di cui dobbiamo andare orgogliosi: di per sé, però, non è un indice del loro inarrestabile declino.
Su due aspetti, infine, va avviata una seria e pacata riflessione che qui possiamo solo accennare. In primo luogo il sistema carcerario. Da più parti si denuncia – anche sulla scorta di puntuali e recenti indagini giudiziarie – che le carceri stanno sfuggendo al controllo dello Stato rivelandosi in alcuni casi come «colabrodo» rispetto alla necessità di impedire agli imputati e condannati per mafia di dominare tra le celle e mantenere rapporti con l’esterno per fini illeciti. Parliamone pure, ma evitiamo approcci esclusivamente «securitari», come sembra trasparire da un’iniziativa promossa dalla magistratura requirente che proprio oggi si tiene a Palermo: il carcere deve essere prima di tutto un luogo di tutela dei diritti individuali e di realizzazione di progetti rieducativi, sennò facilmente diventa «macelleria messicana». In secondo luogo, le indagini in corso sul «passato che non passa» a opera della procura di Caltanissetta che lo scorso 23 aprile ha finalmente ottenuto l’archiviazione della «pista nera», ossia il coinvolgimento di trame neofasciste nelle stragi del 1992. Intendiamoci, la ricerca della verità senza sconti per nessuno è un dovere nei confronti dei familiari delle vittime e dell’intera comunità nazionale. Non è detto, tuttavia, che le indagini dei pubblici ministeri siano in ogni caso il mezzo giusto, soprattutto se ciò rischia di divellere basilari istituti giuridici, snaturare le norme penali e non celebrare comunque alcun vero processo. Anzi, a volte la scure penalistica, per le conseguenze che determina sulle persone coinvolte o solo sfiorate dalle indagini, finisce paradossalmente per allontanarci dalla spiegazione e comprensione di fatti politici e sociali complessi come quelli che affollano quegli eventi terribili. Diamo la storia agli storici e i processi penali al diritto, a ciascuno il suo. Molto meglio.
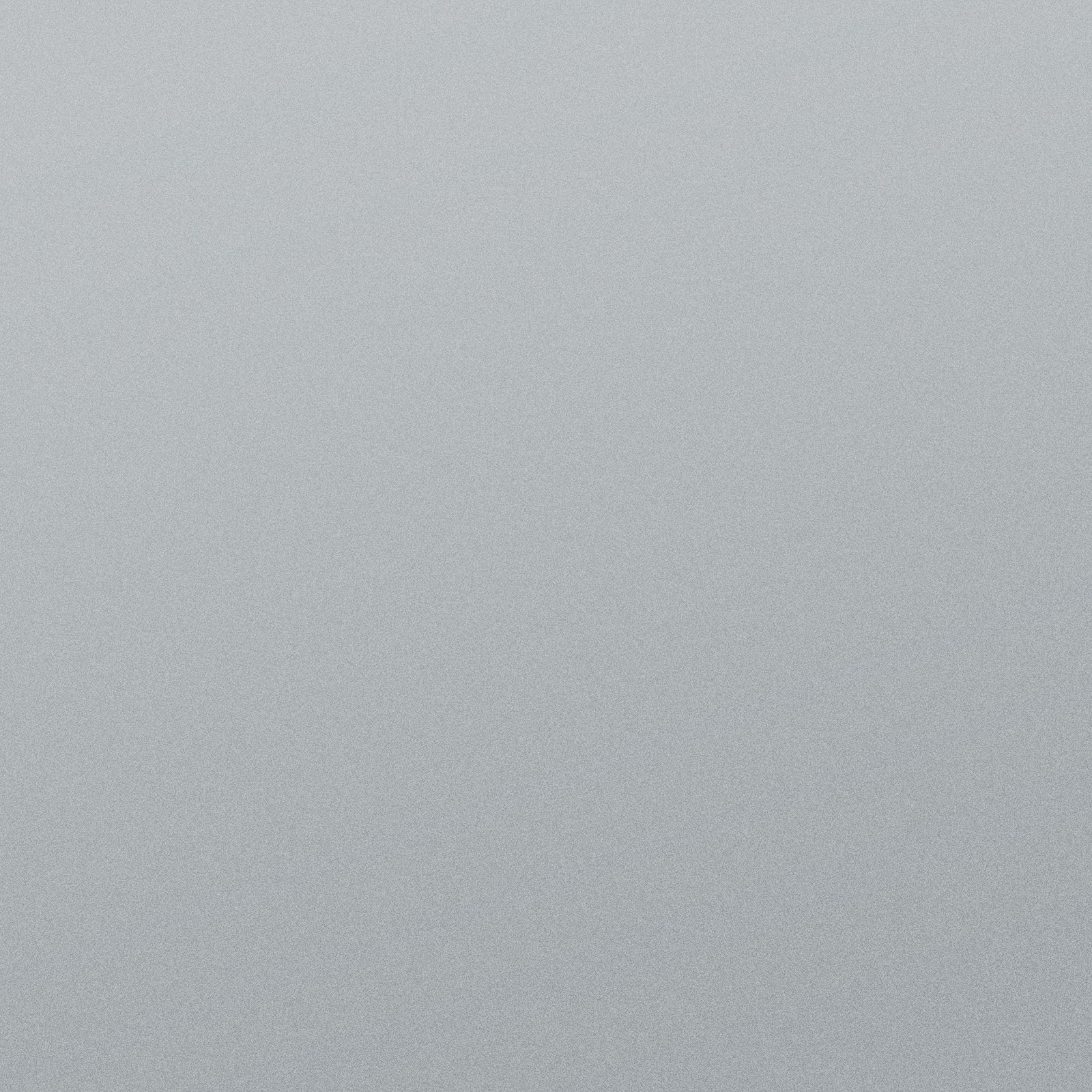
Scopri di più nell’edizione digitale
Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.








Caricamento commenti
Commenta la notizia